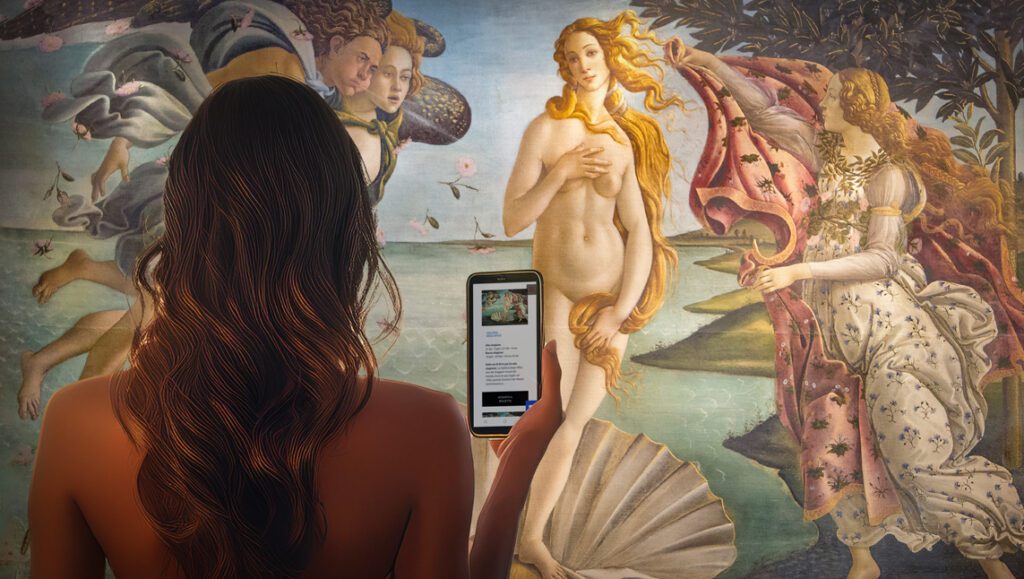I 600 anni della Cappella Brancacci
L’anno 2025 segna un importante anniversario per la storia dell’arte: i seicento anni dalla creazione degli affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci, uno dei luoghi di culto si può dire per gli appassionati dell’arte del primo Rinascimento fiorentino.
Situata all’interno della chiesa di Santa Maria del Carmine in Oltrarno, la cappella è da sempre un punto di riferimento cronologico importante per i suoi affreschi, iniziati da Masolino da Panicale nel 1424 e proseguiti poi da Masaccio dal 1425.
Questi dipinti costituiscono una pietra miliare non solo del Rinascimento, ma anche dell’evoluzione della pittura occidentale. Masaccio, il cui vero nome era Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai (1401-1428) – nato a San Giovanni Valdarno – seppe rivoluzionare la concezione pittorica del proprio tempo mediante l’introduzione di una tecnica innovativa e di un linguaggio figurativo che influenzerà generazioni di artisti. Questo breve articolo intende analizzare il ruolo chiave di Masaccio nel processo di rinnovamento artistico e il significato dei suoi affreschi per la comprensione del Rinascimento fiorentino.
Parola chiave: Prospettiva
Uno degli aspetti più significativi dello stile di Masaccio è la sua padronanza della prospettiva, che egli tradusse in immagini di grande forza espressiva e rigore compositivo. La prospettiva rappresentava una grande portata di novità in quegli anni, dal momento che poco tempo prima le sue regole matematiche erano state codificate da Filippo Brunelleschi, il celebre architetto la cui fama è indissolubilmente legata all’erezione della cupola di Santa Maria del Fiore.
Prima della importante innovazione della prospettiva – e della sua applicazione da parte di Masaccio nella pittura – l’arte di dipingere mostrava una maggiore schematizzazione, sebbene prima di Masaccio alcuni artisti, già nel Trecento, dimostrarono di saper fare qualcosa al riguardo, ma con opportune differenze…
Elemento essenziale che cominciamo a vedere con Masaccio è un punto di fuga unico che permetteva un’organizzazione spaziale tale da favorire la profondità e l’illusione di uno spazio tridimensionale continuo. Ciò è evidente, sempre con Masaccio, nella celeberrima Trinità nella Chiesa di Santa Maria Novella, mentre nella Cappella Brancacci l’artista ‘osa’ creare delle rese spaziali che vanno oltre le architetture per arrivare ad abbracciare il paesaggio.
La Cappella fu commissionata dalla famiglia Brancacci e conserva un ciclo di affreschi che narra episodi della vita di San Pietro. Il contributo di Masaccio, che prosegue come si è detto il lavoro di Masolino da Panicale, si rivela di primaria importanza: il giovane artista vi inserì figure imponenti e solide, rinunciando a qualsiasi tipo di ‘orpello’ come dorature o ricchezza nelle vesti dei personaggi.
Se il ciclo di affreschi raccoglie una serie di suggestioni dove l’osservatore può riflettere sulle novità apportate dal pittore di San Giovanni Valdarno, la più emblematica delle scene di Masaccio è il Pagamento del Tributo, in cui l’artista valdarnese rappresenta con incredibile verosimiglianza il momento in cui Cristo, circondato dagli apostoli, ordina a Pietro di pescare il denaro necessario al pagamento di un tributo. La disposizione dei personaggi attorno a un fuoco prospettico ben definito crea un senso di unità spaziale, mentre l’uso della luce e dell’ombra – che modella i corpi con grande naturalezza – rompe con l’idealizzazione tipica dell’arte gotica.
Il realismo di Masaccio fu percepito come un’autentica rivoluzione: egli dimostrò che le regole matematiche della prospettiva potevano essere adoperate per conferire verità anatomica e solennità spirituale alle figure sacre, senza ridurre la componente devozionale dell’opera. Le sue figure possiedono corpi volumetrici e volti intensi, rendendo gli episodi sacri pienamente aderenti alla realtà umana, dimostrando in questo di volersi rifare al suo ideale modello precedente, ovvero, l’arte di Giotto.
La forza delle novità pittoriche di Masaccio fu enorme: numerosi artisti, tra cui il più celebre fu Michelangelo, si formarono o trovarono ispirazione di fronte agli affreschi nella Cappella Brancacci, riconoscendone il valore rivoluzionario.
Importanti messaggi nascosti dietro al Tributo
Celebrare oggi il seicentesimo anniversario di questi affreschi significa riconoscere come Masaccio abbia posto le basi della pittura rinascimentale, elevandola a strumento di indagine razionale e di rappresentazione verosimile del mondo. La sua applicazione rigorosa delle regole prospettiche e l’attenzione alla rappresentazione anatomica segnarono convenzionalmente il passaggio dalla pittura tardogotica a quella rinascimentale, dando inizio a un percorso di innovazioni che si sarebbe ulteriormente sviluppato con artisti quali Fra’ Angelico e Andrea del Castagno. In definitiva, la Cappella Brancacci resta, a seicento anni di distanza, un monumento imprescindibile per lo studio e la comprensione del Rinascimento e dell’evoluzione del linguaggio pittorico italiano.
Tuttavia, gli affreschi della Cappella Brancacci non sono importanti solo per segnare l’’inizio’ della pittura prospettica, ma anche per esprimere, mediante i gesti e le storie ivi rappresentate, alcuni concetti e messaggi importanti di cui i committenti si fanno portavoce, in una congiuntura storicamente significativa per Firenze in quel torno di anni. Avrai modo di scoprire tutta l’importanza degli affreschi della Cappella Brancacci nel contesto artistico e politico della Firenze di primo Quattrocento attraverso una visita guidata alla cappella ⟢